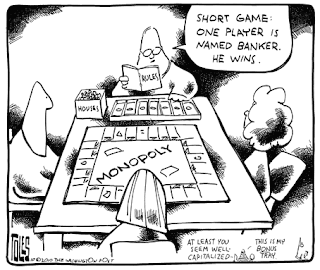Non sono d'accordo con il titolo del grafico di J. Montier (l'unica costante è che tutto cambia!), che tuttavia offre un'irresistibile prospettiva storico-economica in un solo sguardo (click per ingrandire).
Come in innumerevoli altri casi dell'avventura umana, ci sono alcuni tratti ricorrenti nella storia finanziaria. La differenza tra cronaca e analisi sta proprio nel riconoscere l'importanza del cambiamento continuo, ma anche delle determinanti fondamentali dei processi economici. La tendenza dell'indice P/E a muoversi in direzioni abbastanza prevedibili in prossimità di valutazioni estreme è sicuramente una di queste regolarità.
27 dicembre 2010
25 dicembre 2010
Nuova moneta e spinte inflattive: tra il dire e il (poter) fare...
Se acquisto un T-bond (un titolo del Tesoro USA) devo impiegare miei fondi, oppure liquidare altre posizioni in attività per mettere insieme il denaro necessario al fine di acquistare il titolo.
In alternativa, potrei prendere in prestito denaro da una banca e usare i fondi per comprare il titolo "al margine".
Se è una banca centrale - diciamo la Federal Reserve - ad avere lo stesso problema, lo risolve in un altro modo.
Semplicemente accredita all'istante il conto di deposito che il venditore del titolo di stato - una banca commerciale - ha presso di essa. A sua volta, il venditore gira i titoli di stato o le mortgage backed securities alla Fed, che in pratica crea elettronicamente nuova moneta.
Tutta questa moneta, tuttavia, nonostante le pie intenzioni della Fed, non si sta diffondendo granchè nell'economia. La maggior parte è semplicemente parcheggiata nei depositi - chiamate riserve - delle banche commerciali presso la Fed. E' questa la ragione per cui le misure ufficiali dell'offerta di moneta non hanno sinora evidenziato un aumento significativo, che invece si manifesta quando cresce l'ammontare di fondi effettivamente dati in prestito da parte delle banche commerciali. Se dall'inizio del 2008 le riserve bancarie presso la Fed sono passate da 33 a quasi 1000 miliardi di dollari, la moneta in circolazione è cresciuta "solo" del 18%, e la definizione più ristretta di M2 del 3.3% appena.
Supponiamo che a un certo punto gli "spiriti animali" si risveglino e comincino a domandare consistentemente nuovi fondi per investimenti e consumi, così che le banche commerciali traducano in misura massiccia quelle riserve in nuovi impieghi creditizi. Cosa ci salverà, a quel punto, dal potente impulso inflazionistico che molti osservatori, diversi dei quali abbastanza autorevoli, temono da un paio d'anni?
I vertici della Fed rassicurano di avere a disposizione una molteplicità di strumenti per prosciugare l'esorbitante liquidità immessa in questi anni. Una delle possibili leve è il tasso di interesse che la Fed paga sui depositi delle banche commerciali presso di essa. Al momento quel tasso è solo lo 0.25%, e aumentandolo si potrebbe rendere più graduale lo spostamento della liquidità verso un impiego creditizio a ritmi inflazionistici.
Non c'è dubbio che alla Fed non manchino strumenti tecnici in grado di influenzare l'allocazione dei fondi a disposizione delle banche commerciali.
I rischi maggiori riguardano però la reale possibilità che i banchieri centrali avranno di contrapporsi alle richieste di perseverare nel sostegno all'attività economica, specialmente se la ripresa dell'occupazione e dei consumi continuerà a configurarsi come flebile e legata proprio agli interventi delle politiche monetarie e fiscali.
In alternativa, potrei prendere in prestito denaro da una banca e usare i fondi per comprare il titolo "al margine".
Se è una banca centrale - diciamo la Federal Reserve - ad avere lo stesso problema, lo risolve in un altro modo.
Semplicemente accredita all'istante il conto di deposito che il venditore del titolo di stato - una banca commerciale - ha presso di essa. A sua volta, il venditore gira i titoli di stato o le mortgage backed securities alla Fed, che in pratica crea elettronicamente nuova moneta.
Tutta questa moneta, tuttavia, nonostante le pie intenzioni della Fed, non si sta diffondendo granchè nell'economia. La maggior parte è semplicemente parcheggiata nei depositi - chiamate riserve - delle banche commerciali presso la Fed. E' questa la ragione per cui le misure ufficiali dell'offerta di moneta non hanno sinora evidenziato un aumento significativo, che invece si manifesta quando cresce l'ammontare di fondi effettivamente dati in prestito da parte delle banche commerciali. Se dall'inizio del 2008 le riserve bancarie presso la Fed sono passate da 33 a quasi 1000 miliardi di dollari, la moneta in circolazione è cresciuta "solo" del 18%, e la definizione più ristretta di M2 del 3.3% appena.
Supponiamo che a un certo punto gli "spiriti animali" si risveglino e comincino a domandare consistentemente nuovi fondi per investimenti e consumi, così che le banche commerciali traducano in misura massiccia quelle riserve in nuovi impieghi creditizi. Cosa ci salverà, a quel punto, dal potente impulso inflazionistico che molti osservatori, diversi dei quali abbastanza autorevoli, temono da un paio d'anni?
I vertici della Fed rassicurano di avere a disposizione una molteplicità di strumenti per prosciugare l'esorbitante liquidità immessa in questi anni. Una delle possibili leve è il tasso di interesse che la Fed paga sui depositi delle banche commerciali presso di essa. Al momento quel tasso è solo lo 0.25%, e aumentandolo si potrebbe rendere più graduale lo spostamento della liquidità verso un impiego creditizio a ritmi inflazionistici.
Non c'è dubbio che alla Fed non manchino strumenti tecnici in grado di influenzare l'allocazione dei fondi a disposizione delle banche commerciali.
I rischi maggiori riguardano però la reale possibilità che i banchieri centrali avranno di contrapporsi alle richieste di perseverare nel sostegno all'attività economica, specialmente se la ripresa dell'occupazione e dei consumi continuerà a configurarsi come flebile e legata proprio agli interventi delle politiche monetarie e fiscali.
17 dicembre 2010
Questione capitale
Ancora ieri veniva ribadito in sedi molto autorevoli che le banche italiane hanno solida capitalizzazione e che soffriranno in misura limitata per l'entrata in vigore dei nuovi requisiti di capitalizzazione dell'accordo di Basilea III.
In realtà, è anche emerso che dovranno adeguare il loro capitale per almeno 40 miliardi di euro, mentre un'altra provvista di circa 12 miliardi dovrà essere destinata a rimpolpare il fondo di assicurazione sui depositi.
L'indice FTSE MIB a oggi ha perso circa il 2.4% negli ultimi 6 mesi. Nello stesso arco temporale, i titoli dei principali gruppi bancari italiani hanno vissuto performances estremamente deludenti: Unicredit -16%, Intesa Sanpaolo -9.5%, UBI -11%, Banca MPS -12%, Banco Popolare -29%, mentre l'indice settoriale FTSE Italia Banche è sceso del 12.8% circa.
I mercati quindi non condividono granché quelle rassicurazioni, anzi, sebbene rimangano piuttosto scettici sugli effetti realmente stabilizzanti delle nuove norme sul capitale delle banche (vedi per esempio nostri post qui e qui), continuano a punire i titoli delle banche (non solo italiane).
Questo probabilmente accade perché gli investitori sono convinti che di fronte agli effetti dell'ennesima tempesta finanziaria, questa volta del debito pubblico di alcuni paesi europei, il patrimonio degli intermediari bancari sia tutt'altro che sufficiente.
Quale migliore dimostrazione che anche sulla questione della patrimonializzazione delle nostre banche è tempo di abbandonare la retorica rassicurante e adottare rapidamente rigorosi provvedimenti di rinforzo, rivedendo per esempio i piani per le prossime distribuzioni di dividendi?
In realtà, è anche emerso che dovranno adeguare il loro capitale per almeno 40 miliardi di euro, mentre un'altra provvista di circa 12 miliardi dovrà essere destinata a rimpolpare il fondo di assicurazione sui depositi.
L'indice FTSE MIB a oggi ha perso circa il 2.4% negli ultimi 6 mesi. Nello stesso arco temporale, i titoli dei principali gruppi bancari italiani hanno vissuto performances estremamente deludenti: Unicredit -16%, Intesa Sanpaolo -9.5%, UBI -11%, Banca MPS -12%, Banco Popolare -29%, mentre l'indice settoriale FTSE Italia Banche è sceso del 12.8% circa.
I mercati quindi non condividono granché quelle rassicurazioni, anzi, sebbene rimangano piuttosto scettici sugli effetti realmente stabilizzanti delle nuove norme sul capitale delle banche (vedi per esempio nostri post qui e qui), continuano a punire i titoli delle banche (non solo italiane).
Questo probabilmente accade perché gli investitori sono convinti che di fronte agli effetti dell'ennesima tempesta finanziaria, questa volta del debito pubblico di alcuni paesi europei, il patrimonio degli intermediari bancari sia tutt'altro che sufficiente.
Quale migliore dimostrazione che anche sulla questione della patrimonializzazione delle nostre banche è tempo di abbandonare la retorica rassicurante e adottare rapidamente rigorosi provvedimenti di rinforzo, rivedendo per esempio i piani per le prossime distribuzioni di dividendi?
14 dicembre 2010
L’insostenibile leggerezza del tirare a campare
L’economia italiana, al traino dei suoi principali mercati di sbocco, nel 2010 ha ricominciato a crescere, di circa l’1% all’anno. Tuttavia, soprattutto vista dal mercato del lavoro, questa ripresa somiglia molto a una recessione. In realtà, economia e società italiana usciranno dalle secche solo dopo una profonda trasformazione civile e di mentalità.
Mille indicatori confermano che l’economia italiana sta vivendo una crisi al quadrato. Una crisi congiunturale, partita con un tracollo degli ordinativi industriali, poi di produzione e consumi, e infine delle prospettive occupazionali. Questo dentro una crisi strutturale della nostra capacità di generare benessere diffuso, in corso da almeno un quindicennio. Fra i 30 paesi dell’OECD, il prodotto medio di un’ora lavorata è sceso negli ultimi dieci anni solo in un paese: il nostro. L’organizzazione del lavoro e delle aziende in Italia è mediamente inefficiente, e le famiglie italiane vivono da molti anni una decisa perdita di potere d’acquisto.
La nostra è una società sempre meno giovane, quindi meno dinamica e innovativa. Ma anche dominata da una visione dello Stato come motore e trasmissione dell’economia, mentre in economie più vivaci lo Stato regola con efficienza l’iniziativa privata e sostiene pragmaticamente le infrastrutture materiali e immateriali per la crescita.
Questa crisi ha risolto la tensione tra le due forme di intervento pubblico. Semplicemente l’Italia non può più permettersi i termini attuali della sua organizzazione. I nostri conti pubblici sono a un passo dalla sostanziale insolvenza di Grecia, Irlanda e Portogallo, e oltre a limitare fortemente gli investimenti pubblici, il loro squilibrio ha pure distorto il mercato del lavoro, quello dei capitali, la politica.
I giovani sono il cuore del problema, e al tempo stesso la risorsa per risolverlo. Il nostro sistema educativo è così malconcio da spingere il ministro Gelmini all’euforia perchè i dati 2009-2010 hanno collocato la preparazione dei quindicenni italiani al 28° posto su 35 paesi della rilevazione PISA-OECD. Nella fascia d’età 20-24 l’Italia era nel 2007 il paese d’Europa con la più alta percentuale di persone non impegnate in istruzione, al lavoro, o alla sua ricerca. Serve altro per capire che scarsa produttività del sistema industriale e declinante collocazione qualitativa delle produzioni dipendono anche dalla bassa qualità media del “capitale umano”?
Ci sono due sfide di lungo periodo, make or break, che il Paese ha davanti. Una sostanziale riorganizzazione qualitativa del sistema formativo. E una rimodulazione profonda dello Stato sociale, per attenuare gli effetti delle grandi trasformazioni in corso sulle prospettive retributive e previdenziali delle generazioni più giovani. Per sostenere queste riforme occorre un severo dimagrimento della spesa pubblica, e quindi un’iniezione di concreto riformismo nella nostra vita economica e politica. Ce la faremo?
9 dicembre 2010
Previsioni?
Annalisa Rossini, Ina Zhuka, Andrea Bolentini, Stefano Marmentini e Angelo Roversi, studenti del corso di Teoria degli Investimenti, hanno stilato un'articolata serie di previsioni per i mercato azionari italiano, francese, tedesco e USA nel 2011.
Impiegando informazione strutturata in varie configurazioni, dai modelli multifattoriali e semplici regressioni previsionali, gli studenti hanno estrapolato numeri abbastanza ottimistici (positivi) per il mercato azionario italiano e per quelli USA e tedesco, rimanendo invece abbastanza bearish per quello francese.
Al termine dell'esperimento ho condotto un semplice sondaggio su questa classe di studenti di finanza, chiedendo la previsione personale sulla performance del il FTSE MIB nel 2011. La media aritmetica delle previsioni (esclusa quella del docente) fa un bel +0.5%, con una deviazione standard intorno al 4%.
La previsione del docente? La ragione spinge a non fare previsioni, anzi a continuare a pensare che poichè là fuori ci sono ancora diversi elementi di consistente rischio non diversificabile, eventuali revisioni positive sul piano dei cash flows delle imprese possano essere facilmente dominate da scossoni relativi al loro aggiustamento per il rischio.
Finale non entusiasmante, ma realista, credo.
Impiegando informazione strutturata in varie configurazioni, dai modelli multifattoriali e semplici regressioni previsionali, gli studenti hanno estrapolato numeri abbastanza ottimistici (positivi) per il mercato azionario italiano e per quelli USA e tedesco, rimanendo invece abbastanza bearish per quello francese.
Al termine dell'esperimento ho condotto un semplice sondaggio su questa classe di studenti di finanza, chiedendo la previsione personale sulla performance del il FTSE MIB nel 2011. La media aritmetica delle previsioni (esclusa quella del docente) fa un bel +0.5%, con una deviazione standard intorno al 4%.
La previsione del docente? La ragione spinge a non fare previsioni, anzi a continuare a pensare che poichè là fuori ci sono ancora diversi elementi di consistente rischio non diversificabile, eventuali revisioni positive sul piano dei cash flows delle imprese possano essere facilmente dominate da scossoni relativi al loro aggiustamento per il rischio.
Finale non entusiasmante, ma realista, credo.
6 dicembre 2010
200 Paesi in 200 anni
Bellissimo clip (segnalato dal blog di G. Mankiw) sull'evoluzione del reddito pro-capite di 200 Paesi in 200 anni.
2 dicembre 2010
Investitori distratti?
Stefania Bono, Irina Mezzani, Matteo Babaglioni e Matteo Bulgari, studenti del corso di Teoria degli Investimenti, hanno firmato per il corso un'analisi della rilevanza del settore bancario italiano sul listino azionario del nostro Paese, anche in termini di performance storica.
Dallo studio emergono diversi fatti.
Innanzitutto una evidente sproporzione relativa tra la rilevanza dell'attivo di bilancio sul PIL (inferiore a quello di Francia e germania, per esempio) e il peso del settore finanziario sulla capitalizzazione complessiva del mercato azionario (di gran lunga il maggiore in Europa e anche rispetto agli USA).
Poi, una performance abbastanza deludente dei titoli bancari italiani nel periodo 2003-2010, come evidenziato dal grafico in basso (click per ingrandire). Rispetto alle nostre,fanno peggio solo poche grandi banche nei Paesi presi in esame.
La domanda sorge spontanea: se le banche italiane sono davvero più solide degli sventurati peers di altri Paesi vittime di grandi shocks negli anni scorsi, come mai gli investitori non ne premiano le azioni?
Dallo studio emergono diversi fatti.
Innanzitutto una evidente sproporzione relativa tra la rilevanza dell'attivo di bilancio sul PIL (inferiore a quello di Francia e germania, per esempio) e il peso del settore finanziario sulla capitalizzazione complessiva del mercato azionario (di gran lunga il maggiore in Europa e anche rispetto agli USA).
Poi, una performance abbastanza deludente dei titoli bancari italiani nel periodo 2003-2010, come evidenziato dal grafico in basso (click per ingrandire). Rispetto alle nostre,fanno peggio solo poche grandi banche nei Paesi presi in esame.
La domanda sorge spontanea: se le banche italiane sono davvero più solide degli sventurati peers di altri Paesi vittime di grandi shocks negli anni scorsi, come mai gli investitori non ne premiano le azioni?
25 novembre 2010
Stress estivi e collassi invernali
La scorsa estate vennero eseguiti nell'area dell'euro gli ormai celebri stress tests sulle maggiori banche commerciali dell'area. I risultati furono largamente positivi, nel senso che la patrimonializzazione e approvvigionamento di liquidità della stragrande maggioranza degli intermediari sottoposti alle prove vennero presentati come di entità sufficiente da mettere le banche al riparo da rischi di instabilità a fronte di nuovi scossoni dei mercati.
Non mancarono dubbi e polemiche. Da parte di alcuni osservatori si sostenne che i tests mancavano di rigore, perchè per esempio finivano con il diluire il peso dei titoli del debito pubblico detenuti nei bilanci bancari, oppure perchè gli scenari simulati di instabilità finanziaria e macroeconomica apparivano un po' ottimistici.
Le quotazioni persistentemente traballanti di alcuni gruppi bancari europei (anche italiani) lasciano pensare che la loro patrimonializzazione venga percepita dai mercati come tutt'altro che solida.
Ci sono due possibilità.
La prima è che quei tests erano pura finzione, laddove, per esempio, non facevano emergere alcuna problematica significativa per nessuna delle maggiori banche irlandesi per le quali oggi si prospetta un altro round di salvataggi disperati.
La seconda è che i mercati finanziari stiano in realtà scommettendo contro la capacità delle banche di attraversare indenni la congiuntura macroeconomica e le riforme dell'assetto regolamentare che le riguarda. Quella scommessa sembra mettere molto sulla difensiva le autorità monetarie europee, che appaiono incapaci di adottare una strategia credibile di uscita dalla crisi del debito in Europa.
In entrambi i casi sarebbe opportuno ripetere, questa volta in maniera severa, i tests, soprattutto con uno sguardo più occhiuto a realtà bancarie di impatto sistemico più rilevante, e alla luce di scenari macroeconomici più realistici.
Probabilmente ne scaturirebbe una realtà molto meno rassicurante di quella emersa la scorsa estate.
Non mancarono dubbi e polemiche. Da parte di alcuni osservatori si sostenne che i tests mancavano di rigore, perchè per esempio finivano con il diluire il peso dei titoli del debito pubblico detenuti nei bilanci bancari, oppure perchè gli scenari simulati di instabilità finanziaria e macroeconomica apparivano un po' ottimistici.
Le quotazioni persistentemente traballanti di alcuni gruppi bancari europei (anche italiani) lasciano pensare che la loro patrimonializzazione venga percepita dai mercati come tutt'altro che solida.
Ci sono due possibilità.
La prima è che quei tests erano pura finzione, laddove, per esempio, non facevano emergere alcuna problematica significativa per nessuna delle maggiori banche irlandesi per le quali oggi si prospetta un altro round di salvataggi disperati.
La seconda è che i mercati finanziari stiano in realtà scommettendo contro la capacità delle banche di attraversare indenni la congiuntura macroeconomica e le riforme dell'assetto regolamentare che le riguarda. Quella scommessa sembra mettere molto sulla difensiva le autorità monetarie europee, che appaiono incapaci di adottare una strategia credibile di uscita dalla crisi del debito in Europa.
In entrambi i casi sarebbe opportuno ripetere, questa volta in maniera severa, i tests, soprattutto con uno sguardo più occhiuto a realtà bancarie di impatto sistemico più rilevante, e alla luce di scenari macroeconomici più realistici.
Probabilmente ne scaturirebbe una realtà molto meno rassicurante di quella emersa la scorsa estate.
23 novembre 2010
Due spread e due lettere
Il Financial Times del 15 Novembre ha pubblicato una lettera del Direttore Generale del Tesoro Italiano, Vittorio Grilli, in cui il nostro autorevole funzionario lamenta un evidente errore presente in un precedente grafico del giornale, in cui si era erroneamente equiparato la situazione fiscale del nostro Paese a quella dell'Irlanda (Human error magnified on a diabolical scale).
Ora, è pacifico che errori così evidenti dovrebbero essere accuratamente evitati. Il Financial Times è così autorevole proprio perché la sua informazione e analisi sono da sempre di diverse spanne più precise e indipendenti di quanto si trovi sui nostri giornali nazionali.
E' altrettanto pacifico che l'Italia non è come l'Irlanda. La quale però alcuni mesi fa sosteneva di non essere come la Grecia, che a sua volta prometteva di non fare come l'Argentina. In effetti, in questi giorni lo spread dei nostri titoli di stato a 10 anni rispetto ai bund tedeschi è meno di 1/3 del livello irlandese.
Vittorio Grilli è al Ministero dell'Economia dal 1994, tranne che per qualche breve parentesi. Lavora quindi da 16 anni al vertice dell'autorità fiscale di un Paese che quest'anno registrerà un rapporto debito/PIL del 118%, paga 75 miliardi all'anno di interessi su questo debito, e proprio pochi giorni fa ha totalizzato un misero 58/100 nell'Open Budget Survey 2010, indicatore internazionale di trasparenza e efficienza nella gestione del debito pubblico, dietro a fuoriclasse del calibro di Sri Lanka, Ucraina, Colombia e Mongolia (i Paesi migliori sono molto distanti).
All'inizio del 1991 Mario Sarcinelli si dimise da Direttore Generale del Tesoro. Nella lettera di dimissioni Sarcinelli scriveva:
"...Sin dai tempi del liceo, studiando filosofia, etica e morale mi sono sempre chiesto quale è il meccanismo che trasforma in un complice un collaboratore tecnico che lealmente pone a disposizione dei superiori [...] le proprie capacità, competenze e conoscenze per il conseguimento degli obiettivi a lui indicati. Ebbene, non esistendo alcun metodo oggettivo, l'unico al quale si può far ricorso è quello soggettivo; allorché il collaboratore ha dubbi sulla volontà effettiva di coloro che hanno il comando di conseguire gli obiettivi ritenuti indispensabili per la salvezza del Paese [...] egli ha il dovere di dimettersi e se possibile di far conoscere le ragioni del suo abbandono. [...]".
L'Italia non è come l'Irlanda. E evidentemente Grilli ha molti meno dubbi di Sarcinelli.
Ora, è pacifico che errori così evidenti dovrebbero essere accuratamente evitati. Il Financial Times è così autorevole proprio perché la sua informazione e analisi sono da sempre di diverse spanne più precise e indipendenti di quanto si trovi sui nostri giornali nazionali.
E' altrettanto pacifico che l'Italia non è come l'Irlanda. La quale però alcuni mesi fa sosteneva di non essere come la Grecia, che a sua volta prometteva di non fare come l'Argentina. In effetti, in questi giorni lo spread dei nostri titoli di stato a 10 anni rispetto ai bund tedeschi è meno di 1/3 del livello irlandese.
Vittorio Grilli è al Ministero dell'Economia dal 1994, tranne che per qualche breve parentesi. Lavora quindi da 16 anni al vertice dell'autorità fiscale di un Paese che quest'anno registrerà un rapporto debito/PIL del 118%, paga 75 miliardi all'anno di interessi su questo debito, e proprio pochi giorni fa ha totalizzato un misero 58/100 nell'Open Budget Survey 2010, indicatore internazionale di trasparenza e efficienza nella gestione del debito pubblico, dietro a fuoriclasse del calibro di Sri Lanka, Ucraina, Colombia e Mongolia (i Paesi migliori sono molto distanti).
All'inizio del 1991 Mario Sarcinelli si dimise da Direttore Generale del Tesoro. Nella lettera di dimissioni Sarcinelli scriveva:
"...Sin dai tempi del liceo, studiando filosofia, etica e morale mi sono sempre chiesto quale è il meccanismo che trasforma in un complice un collaboratore tecnico che lealmente pone a disposizione dei superiori [...] le proprie capacità, competenze e conoscenze per il conseguimento degli obiettivi a lui indicati. Ebbene, non esistendo alcun metodo oggettivo, l'unico al quale si può far ricorso è quello soggettivo; allorché il collaboratore ha dubbi sulla volontà effettiva di coloro che hanno il comando di conseguire gli obiettivi ritenuti indispensabili per la salvezza del Paese [...] egli ha il dovere di dimettersi e se possibile di far conoscere le ragioni del suo abbandono. [...]".
L'Italia non è come l'Irlanda. E evidentemente Grilli ha molti meno dubbi di Sarcinelli.
Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur
Sono almeno tre settimane che si parla di salvataggio ("bailout") dell'Irlanda da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. I dettagli sembrano praticamente tutti definiti, dall'ammontare complessivo (intorno ai 90 miliardi di euro), alla fetta di tale cifra che ricadrebbe sullo European Financial Stability Fund, il veicolo europeo attivato nella scorsa estate per fronteggiare questa situazioni.
Curiosamente però, l'accordo a portata di mano incontra da giorni ostacoli apparentemente incomprensibili. Al punto che il governo irlandese in carica sta disfacendosi, lasciando il Paese in un pauroso vuoto di responsabilità.
La ragione di tutti questi ritardi sembra che stia in una questione molto semplice: in cambio del sostegno finanziario i Paesi EU chiedono dal governo un impegno a risanare rapidamente i conti del Paese, cominciando da un deciso aumento delle entrate fiscali, e in particolare di quelle legate ai redditi societari.
In effetti, il grafico in basso (click per ingrandire) mostra che il 12.5% irlandese è la più bassa tra le aliquote dei Paesi OECD. Questo spiega l'enorme capacità di attrazione di Dublino per gli investimenti esteri, e il fatto che l'Irlanda sia diventata nel corso degli anni '90 e 2000 l'epicentro di una frenetica attività di localizzazioni (più o meno reali) di tante multinazionali.
Tuttavia, qualche dato ulteriore dimostra che le entrate fiscali di Dublino o di qualunque altro Paese dipendono solo in misura marginale dalle imposte sul reddito societario (3.4% del GDP, contro una media dei Paesi OECD del 3.5%; la Germania incassa solo il 2.2%).
Quindi, è del tutto strumentale bloccare le trattative EU-Irlanda, come stanno facendo le autorità europee, su questa questione di principio. Meglio, diversi membri EU stanno sicuramente approfittando delle difficoltà irlandesi per regolare una partita aperta con quel Paese in tema di concorrenza fiscale: se Dublino aumenta il carico fiscale, qualcun altro si vedrà "regalata" una bella fetta di investimenti diretti all'estero (FDI) in uscita.
Mentre Dublino brucia, a qualcuno viene l'acquolina in bocca. Peccato però che a bruciare non sia solo Dublino...
Curiosamente però, l'accordo a portata di mano incontra da giorni ostacoli apparentemente incomprensibili. Al punto che il governo irlandese in carica sta disfacendosi, lasciando il Paese in un pauroso vuoto di responsabilità.
La ragione di tutti questi ritardi sembra che stia in una questione molto semplice: in cambio del sostegno finanziario i Paesi EU chiedono dal governo un impegno a risanare rapidamente i conti del Paese, cominciando da un deciso aumento delle entrate fiscali, e in particolare di quelle legate ai redditi societari.
In effetti, il grafico in basso (click per ingrandire) mostra che il 12.5% irlandese è la più bassa tra le aliquote dei Paesi OECD. Questo spiega l'enorme capacità di attrazione di Dublino per gli investimenti esteri, e il fatto che l'Irlanda sia diventata nel corso degli anni '90 e 2000 l'epicentro di una frenetica attività di localizzazioni (più o meno reali) di tante multinazionali.
Tuttavia, qualche dato ulteriore dimostra che le entrate fiscali di Dublino o di qualunque altro Paese dipendono solo in misura marginale dalle imposte sul reddito societario (3.4% del GDP, contro una media dei Paesi OECD del 3.5%; la Germania incassa solo il 2.2%).
Quindi, è del tutto strumentale bloccare le trattative EU-Irlanda, come stanno facendo le autorità europee, su questa questione di principio. Meglio, diversi membri EU stanno sicuramente approfittando delle difficoltà irlandesi per regolare una partita aperta con quel Paese in tema di concorrenza fiscale: se Dublino aumenta il carico fiscale, qualcun altro si vedrà "regalata" una bella fetta di investimenti diretti all'estero (FDI) in uscita.
Mentre Dublino brucia, a qualcuno viene l'acquolina in bocca. Peccato però che a bruciare non sia solo Dublino...
21 novembre 2010
C'è qualcosa che non funziona...
Federica Bosio, Paola Ferrari, Andrea Battagliola e Antonio Trombini, studenti del mio corso di Teoria degli Investimenti, hanno elaborato un accurato studio sulla performance relativa del mercato azionario italiano rispetto ai principali indici azionari europei e globali per gli ultimi 10 anni.
Il risultato principale è che in termini di rendimento i nostri principali indici hanno fatto molto peggio di quasi tutti i benchmarks, e si sono anche distinti per elevata volatilità. Il grafico in basso (click per ingrandire) ne è una testimonianza molto chiara.
Naturalmente le ragioni di questa prestazione deludente (il mercato italiano oggi vale poco più del 40% del suo livello di 10 anni fa, mentre per esempio l'indice tedesco DAX vale circa l'80%) sono molteplici e tutt'altro che facilmente determinabili. La scarsa capacità dell'economia italiana di generare crescita, profitti e benessere quanto i suoi peers dovrebbe comunque essere parte della spiegazione, o no?
Il risultato principale è che in termini di rendimento i nostri principali indici hanno fatto molto peggio di quasi tutti i benchmarks, e si sono anche distinti per elevata volatilità. Il grafico in basso (click per ingrandire) ne è una testimonianza molto chiara.
Naturalmente le ragioni di questa prestazione deludente (il mercato italiano oggi vale poco più del 40% del suo livello di 10 anni fa, mentre per esempio l'indice tedesco DAX vale circa l'80%) sono molteplici e tutt'altro che facilmente determinabili. La scarsa capacità dell'economia italiana di generare crescita, profitti e benessere quanto i suoi peers dovrebbe comunque essere parte della spiegazione, o no?
16 novembre 2010
Don't look back in anger...
Dorina Tagliani, Paolo Cattafesta, Mattia Ribola e Matteo Rosina, studenti del mio corso di Teoria degli Investimenti, hanno preparato una bella analisi di performance sulle asset classes di maggior successo degli ultimi 10 anni. Il grafico in basso riporta l'andamento normalizzato delle serie storiche (click per ingrandire):
Le categorie caratterizzate da rendimenti complessivi più elevati (ma anche volatilità maggiore) includono indici azionari di paesi emergenti come Brasile, India, Indonesia e Cina, e indici riguardanti materie prime o metalli preziosi. Insomma, i grandi vincitori di questo decennio sono direttamente o indirettamente le commodities e i paesi ad elevata crescita industriale. Cosa ci prepara il prossimo decennio?
Le categorie caratterizzate da rendimenti complessivi più elevati (ma anche volatilità maggiore) includono indici azionari di paesi emergenti come Brasile, India, Indonesia e Cina, e indici riguardanti materie prime o metalli preziosi. Insomma, i grandi vincitori di questo decennio sono direttamente o indirettamente le commodities e i paesi ad elevata crescita industriale. Cosa ci prepara il prossimo decennio?
11 novembre 2010
La ripresa dipende dalle banche
Un gruppo di autorevoli economisti finanziari ha inviato una lettera aperta al Financial Times (Much More Bank Equity Is Needed and Is Not Socially Costly) in cui sollecita le autorità di regolazione bancaria e finanziaria del mondo a rafforzare in misura molto significativa i requisiti di capitalizzazione degli intermediari finanziari.
La linea del loro ragionamento è netta.
L'evidenza teorica ed empirica disponibile dimostra che i costi della raccolta bancaria non sono influenzati dai requisiti di capitale, come invece sostengono le associazioni bancarie. Al contrario, un eccesso di leva finanziaria tende a distorcere incentivi e comportamenti delle banche, con forti rischi a carico di creditori e contribuenti, come l'ultima crisi ha ampiamente dimostrato.
Inoltre, l'impiego come quasi-capitale, consentito dagli accordi di Basilea in base a un sistema risk-weighted, di strumenti sintetici diversi dal semplice capitale azionario, determina un aumento del rischio sistemico e un indebolimento dei poteri regolatori delle autorità.
Per queste ragioni, il gruppo di economisti afferma che "i meccanismi di finanziamento degli investimenti migliorerebbero con [l'adozione, n.d.c] di requisiti di capitale più elevati e appropriati" rispetto a quelli prospettati dal recente accordo di Basilea III.
Questa rigorosa presa di posizione dimostra che la preoccupazione circa il ripetersi di crisi sistemiche come quella vissuta nel 2008-2009 è condivisa da una parte non irrilevante del mondo accademico.
L'adozione (o la mancata adozione) di decisioni vincolanti in misura sostanziale il comportamento degli intermediari finanziari ha implicazioni di forte impatto sulla stabilità finanziaria dei prossimi anni. Ma anche sulle chances che il sistema economico ha di imboccare un sentiero di crescita finanziariamente sostenibile, che al momento ancora non si vede.
La linea del loro ragionamento è netta.
L'evidenza teorica ed empirica disponibile dimostra che i costi della raccolta bancaria non sono influenzati dai requisiti di capitale, come invece sostengono le associazioni bancarie. Al contrario, un eccesso di leva finanziaria tende a distorcere incentivi e comportamenti delle banche, con forti rischi a carico di creditori e contribuenti, come l'ultima crisi ha ampiamente dimostrato.
Inoltre, l'impiego come quasi-capitale, consentito dagli accordi di Basilea in base a un sistema risk-weighted, di strumenti sintetici diversi dal semplice capitale azionario, determina un aumento del rischio sistemico e un indebolimento dei poteri regolatori delle autorità.
Per queste ragioni, il gruppo di economisti afferma che "i meccanismi di finanziamento degli investimenti migliorerebbero con [l'adozione, n.d.c] di requisiti di capitale più elevati e appropriati" rispetto a quelli prospettati dal recente accordo di Basilea III.
Questa rigorosa presa di posizione dimostra che la preoccupazione circa il ripetersi di crisi sistemiche come quella vissuta nel 2008-2009 è condivisa da una parte non irrilevante del mondo accademico.
L'adozione (o la mancata adozione) di decisioni vincolanti in misura sostanziale il comportamento degli intermediari finanziari ha implicazioni di forte impatto sulla stabilità finanziaria dei prossimi anni. Ma anche sulle chances che il sistema economico ha di imboccare un sentiero di crescita finanziariamente sostenibile, che al momento ancora non si vede.
5 novembre 2010
Tutto quello che volevate sapere e non avete ancora capito del QE2
Bellissimo intervento didascalico di Campbell Harvey (Duke University) sul QE2, da The Street. Credo abbia ragione.
4 novembre 2010
This time is really different
In un intervento estremamente interessante sul Washington Post di oggi, Ben Bernanke difende la decisione di ieri del FOMC di estendere di 600 miliardi di dollari il programma di acquisto di Treasuries a lunga scadenza da parte della Fed.
Nell'articolo, il chairman chiarisce molto bene le motivazioni della decisione:
"This approach eased financial conditions in the past and, so far, looks to be effective again. Stock prices rose and long-term interest rates fell when investors began to anticipate the most recent action. Easier financial conditions will promote economic growth. For example, lower mortgage rates will make housing more affordable and allow more homeowners to refinance. Lower corporate bond rates will encourage investment. And higher stock prices will boost consumer wealth and help increase confidence, which can also spur spending. Increased spending will lead to higher incomes and profits that, in a virtuous circle, will further support economic expansion."
Bernanke negli anni scorsi aveva più volte affermato che non è appropriato che la banca centrale intervenga per evitare il formarsi di bolle speculative nei mercati degli assets. L'opinione dominante nel central banking è che nel tentativo di rallentare la dotcom mania della fine degli anni '90 e l'irresistibile ascesa del settore immobiliare dal 2002 in avanti, fenomeni a monte delle ultime due recessioni, i rischi di una manovra restrittiva di politica monetaria supererebbero, per varie ragioni, i benefici.
Oggi apprendiamo invece che in questa visione la crescita dei prezzi degli assets è diventata un obiettivo (intermedio?) della politica monetaria.
Dalla Greenspan put alla Bernanke put. Se solo funzionasse...
Nell'articolo, il chairman chiarisce molto bene le motivazioni della decisione:
"This approach eased financial conditions in the past and, so far, looks to be effective again. Stock prices rose and long-term interest rates fell when investors began to anticipate the most recent action. Easier financial conditions will promote economic growth. For example, lower mortgage rates will make housing more affordable and allow more homeowners to refinance. Lower corporate bond rates will encourage investment. And higher stock prices will boost consumer wealth and help increase confidence, which can also spur spending. Increased spending will lead to higher incomes and profits that, in a virtuous circle, will further support economic expansion."
Bernanke negli anni scorsi aveva più volte affermato che non è appropriato che la banca centrale intervenga per evitare il formarsi di bolle speculative nei mercati degli assets. L'opinione dominante nel central banking è che nel tentativo di rallentare la dotcom mania della fine degli anni '90 e l'irresistibile ascesa del settore immobiliare dal 2002 in avanti, fenomeni a monte delle ultime due recessioni, i rischi di una manovra restrittiva di politica monetaria supererebbero, per varie ragioni, i benefici.
Oggi apprendiamo invece che in questa visione la crescita dei prezzi degli assets è diventata un obiettivo (intermedio?) della politica monetaria.
Dalla Greenspan put alla Bernanke put. Se solo funzionasse...
3 novembre 2010
Le 50 banche più grandi del mondo
Il bel grafico qui sotto tratto da The Banker (click per ingrandire) mostra il ranking delle più 50 grandi banche del mondo, la dimensione dei rispettivi assets, la loro capitalizzazione di mercato corrente e la sua variazione negli ultimi dodici mesi:
Da notare che le banche in assoluto più grandi sono britanniche, tedesche e francesi, e che il valore di mercato del settore continua a scendere vistosamente...
Da notare che le banche in assoluto più grandi sono britanniche, tedesche e francesi, e che il valore di mercato del settore continua a scendere vistosamente...
2 novembre 2010
E gli USA?
Bel grafico sul debito pubblico netto (ossia quello detenuto da investitori privati) degli USA, in percentuale sul PIL, dal 1790 al 2009 (click per ingrandire):
29 ottobre 2010
Scusi, quanto dista la Grecia?
Come mostra il grafico in basso (click per ingrandire) con dati che arrivano al 2009, ciò che distingue maggiormente il rapporto debito pubblico/PIL Italiano rispetto a quasi tutti quelli degli altri Paesi europei è il suo livello e la sua tendenza alla stazionarietà/crescita, soprattutto dalla metà degli anni '90 in avanti. Da quel periodo, infatti molte altre economie, grazie anche a tassi di crescita più sostenuti, hanno visto scendere sensibilmente il loro indebitamento, nuovamente in crescita a partire dall'inizio della crisi nel 2007.
A parte gli esemplari Svedesi e Finlandesi (alte tasse e basso debito, formidabile!), la crisi ha colpito Irlanda, Spagna e UK quando questi Paesi registravano livelli relativamente contenuti di debito, e oggi stanno reagendo (forse anche troppo energicamente) per mantenerli al di sotto di livelli considerati inaccettabili per l'ipoteca che potrebbero imporre alla crescita futura.
L'Italia come al solito sembra in un mondo a parte. E non ci si può certo consolare per la vicinanza della Grecia.
A parte gli esemplari Svedesi e Finlandesi (alte tasse e basso debito, formidabile!), la crisi ha colpito Irlanda, Spagna e UK quando questi Paesi registravano livelli relativamente contenuti di debito, e oggi stanno reagendo (forse anche troppo energicamente) per mantenerli al di sotto di livelli considerati inaccettabili per l'ipoteca che potrebbero imporre alla crescita futura.
L'Italia come al solito sembra in un mondo a parte. E non ci si può certo consolare per la vicinanza della Grecia.
27 ottobre 2010
Regalo di Paulson, ma finanziato dai contribuenti, anche quelli futuri
In uno studio in via di pubblicazione sul Journal of Financial Economics (Paulson's Gift), gli economisti Pietro Veronesi (che insegnò per 8 anni al Master in Moneta e Finanza della nostra Università) e Luigi Zingales della University of Chicago analizzano le conseguenze economiche del piano di salvataggio delle maggiori 10 banche statunitensi ideato nell'ottobre 2008 dall'allora segretario al Tesoro USA Hank Paulson. L'articolo è scaricabile da qui, mentre qui si può trovare una buona sintesi.
Gli autori dimostrano che il piano, che effettivamente impedì la definitiva autodistruzione del sistema bancario USA (e non solo), impose condizioni che si rivelarono estremamente vantaggiose soprattutto per i detentori di obbligazioni delle banche, mentre il guadagno netto per il Tesoro, che iniettò 125 miliardi di dollari di capitali freschi nelle banche sotto forma di azioni privilegiate, fu molto limitato.
Ancora più importante, le conseguenze di lungo termine del piano implicano che dopo di esso le grandi banche sono ancora più convinte che il governo interverrà in loro soccorso e ad ogni costo in futuri nuovi casi di potenziale insolvenza. Anche per questo motivo, che ha a che fare con una situazione chiarissima di moral hazard, le banche avranno un forte incentivo ad attuare pratiche e comportamenti più rischiosi, per se e per il sistema economico-finanziario, proprio perchè sanno di godere di un'implicita assicurazione collettiva. Altra ragione (vedi i due post precedenti) per imporre alle banche, soprattutto quelle maggiori, di dotarsi di cuscinetti di capitale particolarmente spessi.
Gli autori dimostrano che il piano, che effettivamente impedì la definitiva autodistruzione del sistema bancario USA (e non solo), impose condizioni che si rivelarono estremamente vantaggiose soprattutto per i detentori di obbligazioni delle banche, mentre il guadagno netto per il Tesoro, che iniettò 125 miliardi di dollari di capitali freschi nelle banche sotto forma di azioni privilegiate, fu molto limitato.
Ancora più importante, le conseguenze di lungo termine del piano implicano che dopo di esso le grandi banche sono ancora più convinte che il governo interverrà in loro soccorso e ad ogni costo in futuri nuovi casi di potenziale insolvenza. Anche per questo motivo, che ha a che fare con una situazione chiarissima di moral hazard, le banche avranno un forte incentivo ad attuare pratiche e comportamenti più rischiosi, per se e per il sistema economico-finanziario, proprio perchè sanno di godere di un'implicita assicurazione collettiva. Altra ragione (vedi i due post precedenti) per imporre alle banche, soprattutto quelle maggiori, di dotarsi di cuscinetti di capitale particolarmente spessi.
26 ottobre 2010
Non siamo soli...
Buon tempismo (vedi post precedente):
BoE's King says Basel III is not enough to prevent crises
Mervyn King, governor of the Bank of England, said tougher rules established by the Basel Committee on Banking Supervision are not enough to prevent repeats of the financial crisis. "If it is a giant leap for the regulators of the world, it is only a small step for mankind," he said. "Basel III on its own will not prevent another crisis." King also said banks should reduce their reliance on short-term debt and raise more money from stock investors. "The broad answer to the problem is likely to be remarkably simple," King said. "Banks should be financed much more heavily by equity rather than short-term debt -- much, much more equity; much, much less short-term debt". (Bloomberg)
BoE's King says Basel III is not enough to prevent crises
Mervyn King, governor of the Bank of England, said tougher rules established by the Basel Committee on Banking Supervision are not enough to prevent repeats of the financial crisis. "If it is a giant leap for the regulators of the world, it is only a small step for mankind," he said. "Basel III on its own will not prevent another crisis." King also said banks should reduce their reliance on short-term debt and raise more money from stock investors. "The broad answer to the problem is likely to be remarkably simple," King said. "Banks should be financed much more heavily by equity rather than short-term debt -- much, much more equity; much, much less short-term debt". (Bloomberg)
Costly talk
C'è un istruttivo parallelo tra la proposta della Commissione Europea sulla "governance economica" dell'Unione Europea, in particolare le parti concernenti i meccanismi di regolazione e sanzione degli squilibri di bilancio pubblico degli Stati Membri, e quella comunemente nota come "Basilea III", che riguarda i requisiti minimi di capitale delle banche.
Le autorità preposte si sono date il compito di progettare meccanismi in grado di impedire, rispettivamente, l'accumulo di deficit e debiti pubblici eccessivi, e il ripetersi di una crisi finanziaria sistemica come quella del 2007-2009. Il risultato più importante delle elaborate discussioni e contrattazioni sono due regole.
Basilea III fissa un nuovo rapporto minimo di capitale del 4.5%, più del doppio del livello previsto correntemente (2%), più un ulteriore 2.5%. Le banche il cui capitale ricade al di sotto di questo numero dovranno limitare la distribuzione di dividendi e bonus discrezionali; quindi il requisito effettivo è del 7%. Le nuove regole si applicheranno a partire dal Gennaio 2013 e diverranno definitive nel Gennaio 2019.
Il 7% rappresenta un cuscinetto troppo esile in presenza di perturbazioni dei mercati finanziari come quelle cui assistiamo da più di tre anni. In presenza di continua innovazione finanziaria, incertezza regolamentare e rischio sistemico da moral hazard (altro problema malamente affrontato dalle autorità nazionali e internazionali), sarebbe stato molto più appropriato identificare rapporti del 15 o 20% e centrarli su categorie "solide" di capitale, come le azioni. Inoltre, dare alle banche ben nove anni per adeguarsi alle nuove regole e forse per annacquarle attraverso attività di lobbying o cattura dei regolatori significa esporre il sistema finanziario al rischio di nuovi scossoni in presenza di altri episodi di instabilità finanziaria, sempre più frequenti.
Invece, la proposta della Commissione Europea, ancora in fase di rinegoziazione, fissa una serie di meccanismi disegnati per limitare un'eccessiva espansività delle politiche fiscali degli Stati Membri. Questi ricevono addirittura sanzioni pecuniarie se deficit e debiti nazionali non si incamminano su un percorso di convergenza su livelli bassi, come il 60% per il rapporto debito pubblico/PIL. Tuttavia, al termine di un'intensa attività di horse trading, la proposta prevede anche che le sanzioni e i vincoli vengano parecchio mitigati se il paese in questione vive una condizione di particolare stress macroeconomico, oppure se ha un livello contenuto di debito privato, e altro ancora. Insomma, da simulazioni ex post, pare che nessuno degli attuali Stati Membri rischi al momento di essere seriamente "richiamato".
La mancanza di credibilità dei meccanismi sanzionatori è chiaramente il limite comune di Basilea III e delle regole europee. Le nuove regole sul capitale sarebbero davvero efficaci se riuscissero a far scendere in misura significativa e molto prima del 2019 la quota dei profitti dell'industria finanziaria sui profitti totali dell'economia, e se soprattutto gli intermediari più grandi fossero costretti a rinunciare a quote importanti dei profitti per irrobustire fino appunto al 15-20% la propria capitalizzazione.
Se tre dei quattro paesi con il più alto rapporto debito pubblico/PIL al mondo (Italia, Grecia e Belgio) non rientrano tra i "cattivi" secondo la nuova governance economica europea, non si capisce che effetto disciplinante essa possa esercitare. Anche perchè i primi a violare la versione precedente di queste regole, il Patto di Stabilità e Crescita, furono i maggiori Paesi EU, Francia e Germania in testa, già nel 2002-2003.
In entrambi i casi si potrebbe parlare quindi di cheap talk, ossia di chiacchiericcio gratuito, sterile perché incapace di risolvere effettivamente i problemi. In realtà, visto che la fiducia nell'industria finanziaria e nel futuro stenta a ritornare tra investitori e consumatori, e visto che qualche effetto negativo i grandi debiti pubblici continuano ad esercitarlo, queste chiacchiere sono tutt'altro che cheap.
Le autorità preposte si sono date il compito di progettare meccanismi in grado di impedire, rispettivamente, l'accumulo di deficit e debiti pubblici eccessivi, e il ripetersi di una crisi finanziaria sistemica come quella del 2007-2009. Il risultato più importante delle elaborate discussioni e contrattazioni sono due regole.
Basilea III fissa un nuovo rapporto minimo di capitale del 4.5%, più del doppio del livello previsto correntemente (2%), più un ulteriore 2.5%. Le banche il cui capitale ricade al di sotto di questo numero dovranno limitare la distribuzione di dividendi e bonus discrezionali; quindi il requisito effettivo è del 7%. Le nuove regole si applicheranno a partire dal Gennaio 2013 e diverranno definitive nel Gennaio 2019.
Il 7% rappresenta un cuscinetto troppo esile in presenza di perturbazioni dei mercati finanziari come quelle cui assistiamo da più di tre anni. In presenza di continua innovazione finanziaria, incertezza regolamentare e rischio sistemico da moral hazard (altro problema malamente affrontato dalle autorità nazionali e internazionali), sarebbe stato molto più appropriato identificare rapporti del 15 o 20% e centrarli su categorie "solide" di capitale, come le azioni. Inoltre, dare alle banche ben nove anni per adeguarsi alle nuove regole e forse per annacquarle attraverso attività di lobbying o cattura dei regolatori significa esporre il sistema finanziario al rischio di nuovi scossoni in presenza di altri episodi di instabilità finanziaria, sempre più frequenti.
Invece, la proposta della Commissione Europea, ancora in fase di rinegoziazione, fissa una serie di meccanismi disegnati per limitare un'eccessiva espansività delle politiche fiscali degli Stati Membri. Questi ricevono addirittura sanzioni pecuniarie se deficit e debiti nazionali non si incamminano su un percorso di convergenza su livelli bassi, come il 60% per il rapporto debito pubblico/PIL. Tuttavia, al termine di un'intensa attività di horse trading, la proposta prevede anche che le sanzioni e i vincoli vengano parecchio mitigati se il paese in questione vive una condizione di particolare stress macroeconomico, oppure se ha un livello contenuto di debito privato, e altro ancora. Insomma, da simulazioni ex post, pare che nessuno degli attuali Stati Membri rischi al momento di essere seriamente "richiamato".
La mancanza di credibilità dei meccanismi sanzionatori è chiaramente il limite comune di Basilea III e delle regole europee. Le nuove regole sul capitale sarebbero davvero efficaci se riuscissero a far scendere in misura significativa e molto prima del 2019 la quota dei profitti dell'industria finanziaria sui profitti totali dell'economia, e se soprattutto gli intermediari più grandi fossero costretti a rinunciare a quote importanti dei profitti per irrobustire fino appunto al 15-20% la propria capitalizzazione.
Se tre dei quattro paesi con il più alto rapporto debito pubblico/PIL al mondo (Italia, Grecia e Belgio) non rientrano tra i "cattivi" secondo la nuova governance economica europea, non si capisce che effetto disciplinante essa possa esercitare. Anche perchè i primi a violare la versione precedente di queste regole, il Patto di Stabilità e Crescita, furono i maggiori Paesi EU, Francia e Germania in testa, già nel 2002-2003.
In entrambi i casi si potrebbe parlare quindi di cheap talk, ossia di chiacchiericcio gratuito, sterile perché incapace di risolvere effettivamente i problemi. In realtà, visto che la fiducia nell'industria finanziaria e nel futuro stenta a ritornare tra investitori e consumatori, e visto che qualche effetto negativo i grandi debiti pubblici continuano ad esercitarlo, queste chiacchiere sono tutt'altro che cheap.
22 ottobre 2010
Il lungo periodo?
Vale sempre la pena dare uno sguardo periodico al celebre grafico di R. Shiller sulle valutazioni di lungo termine del mercato azionario. La serie storica più importante, il CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio), scala l'indice azionario statunitense S&P500 con la media mobile a 10 anni degli utili delle imprese quotate, offrendo così un indicatore del livello di valutazione del mercato non viziato dalla volatilità di breve termine degli utili.
Il dato al 5 ottobre mostra un valore di 21.17, al di sopra della media sull'intero campione, ma sostanzialmente al di sotto dei picchi vertiginosi degli ultimi 15 anni.
In prospettiva, tutto dipende dalla robustezza degli utili dei prossimi anni. Se la debolezza relativa del ciclo economico americano dovesse continuare a generare buoni utili ma a fronte di fatturati non entusiasmanti come accade in questi mesi, potremo guardare al valore non troppo elevato del PE di oggi come una valutazione realistica, o addirittura ottimistica. Restano fuori da queste congetture considerazioni relative all'inflazione e alla stabilità finanziaria, che come hanno mostrato gli anni '70 e 2000 hanno effetti notevoli nel medio-lungo termine sulle quotazioni.
Il dato al 5 ottobre mostra un valore di 21.17, al di sopra della media sull'intero campione, ma sostanzialmente al di sotto dei picchi vertiginosi degli ultimi 15 anni.
In prospettiva, tutto dipende dalla robustezza degli utili dei prossimi anni. Se la debolezza relativa del ciclo economico americano dovesse continuare a generare buoni utili ma a fronte di fatturati non entusiasmanti come accade in questi mesi, potremo guardare al valore non troppo elevato del PE di oggi come una valutazione realistica, o addirittura ottimistica. Restano fuori da queste congetture considerazioni relative all'inflazione e alla stabilità finanziaria, che come hanno mostrato gli anni '70 e 2000 hanno effetti notevoli nel medio-lungo termine sulle quotazioni.
20 ottobre 2010
Don't ask, don't tell...
Uno studio elaborato da Barclays Capital e diffuso ieri ha mostrato i risultati di un'indagine sulle opinioni di investitori e imprese nei confronti dei problemi legati alla crisi del debito sovrano in Europa.
L'82% dei quasi 600 clienti intervistati, che includono hedge funds, trading desks bancari e società di investimento, afferma di aspettarsi ancora una vera e propria crisi della zona euro, una ristrutturazione del debito o un default da un paese dell'area.
L'82% dei quasi 600 clienti intervistati, che includono hedge funds, trading desks bancari e società di investimento, afferma di aspettarsi ancora una vera e propria crisi della zona euro, una ristrutturazione del debito o un default da un paese dell'area.
19 ottobre 2010
Chi sostiene il mercato azionario?
Tra gli analisti finanziari americani è ormai dominante la convinzione che agli inizi di novembre la Federal Reserve varerà un nuovo programma di quantitative easing, attraverso l'acquisto di titoli del Tesoro americano e altre attività finanziarie, forse anche private.
Lo scopo dichiarato dello stimolo in questione è quello di favorire ulteriormente le condizioni di accesso al credito da parte di imprese e famiglie, quindi sostenendone la domanda di investimenti e consumi.
Poiché i tassi di interesse, a breve come a lunga scadenza, sono già ai minimi storici di lunghissimo periodo (il rendimento sul T-bond decennale ha toccato il 2.3% qualche giorno fa) diversi economisti, anche all'interno della Fed, si interrogano sui benefici della manovra.
Nessuno conosce gli effetti di politiche eterodosse così estese, che con i round precedenti hanno portato a una triplicazione del bilancio della Fed.
Ci sono poi interrogativi sulle reali intenzioni della Fed. Le aspettative inflazionistiche di lungo termine hanno cominciato a muoversi verso l'alto, evidenziando quindi che i mercati un certo impatto inflazionistico lo intravvedono. Secondo alcuni però il vero obiettivo della Fed sarebbe un boost poderoso alle valutazioni di alcune categorie di asset, la cui rivalutazione sarebbe vista come cruciale per far ripartire, principalmente attraverso un effetto ricchezza, ma non solo, la domanda aggregata.
Quotazioni azionarie e immobiliari in forte ripresa potrebbero veramente essere i principali beneficiari del QE2. Tuttavia, i principali indici azionari sembrano aver già anticipato almeno una parte di questa ulteriore somministrazione di "liquidità ad alto potenziale". Le quotazioni immobiliari tendono a reagire più lentamente, mentre la discesa dei rendimenti sui bonds e l'impennata di oro e alcune materie prime segnalano che un primo rally da QE2 alcuni mercati lo hanno già vissuto.
Ci sono diversi rischi. Primo, il dollaro USA potrebbe accelerare il suo deprezzamento, innescando una rincorsa multilaterale alla svalutazione che alla fine danneggerebbe la domanda aggregata di tutti i Paesi. Secondo, se le aspettative di inflazione e di instabilità valutaria e finanziaria dovessero riprendere corpo, l'effetto netto sui tassi di interesse potrebbe addirittura essere al rialzo, con evidenti ripercussioni negative su congiuntura e finanza pubblica. Terzo, l'uscita dalla recessione 2007-2009 è da attribuire in larga parte a manovre fiscali e monetarie a grande scala, dalle quali l'espansione economica sembra essere diventata dipendente, con ovvie controindicazioni.
Infine, è prudente far decidere alla banca centrale il livello "giusto", cioè coerente con l'equilibrio macroeconomico, di valutazione degli asset?
Lo scopo dichiarato dello stimolo in questione è quello di favorire ulteriormente le condizioni di accesso al credito da parte di imprese e famiglie, quindi sostenendone la domanda di investimenti e consumi.
Poiché i tassi di interesse, a breve come a lunga scadenza, sono già ai minimi storici di lunghissimo periodo (il rendimento sul T-bond decennale ha toccato il 2.3% qualche giorno fa) diversi economisti, anche all'interno della Fed, si interrogano sui benefici della manovra.
Nessuno conosce gli effetti di politiche eterodosse così estese, che con i round precedenti hanno portato a una triplicazione del bilancio della Fed.
Ci sono poi interrogativi sulle reali intenzioni della Fed. Le aspettative inflazionistiche di lungo termine hanno cominciato a muoversi verso l'alto, evidenziando quindi che i mercati un certo impatto inflazionistico lo intravvedono. Secondo alcuni però il vero obiettivo della Fed sarebbe un boost poderoso alle valutazioni di alcune categorie di asset, la cui rivalutazione sarebbe vista come cruciale per far ripartire, principalmente attraverso un effetto ricchezza, ma non solo, la domanda aggregata.
Quotazioni azionarie e immobiliari in forte ripresa potrebbero veramente essere i principali beneficiari del QE2. Tuttavia, i principali indici azionari sembrano aver già anticipato almeno una parte di questa ulteriore somministrazione di "liquidità ad alto potenziale". Le quotazioni immobiliari tendono a reagire più lentamente, mentre la discesa dei rendimenti sui bonds e l'impennata di oro e alcune materie prime segnalano che un primo rally da QE2 alcuni mercati lo hanno già vissuto.
Ci sono diversi rischi. Primo, il dollaro USA potrebbe accelerare il suo deprezzamento, innescando una rincorsa multilaterale alla svalutazione che alla fine danneggerebbe la domanda aggregata di tutti i Paesi. Secondo, se le aspettative di inflazione e di instabilità valutaria e finanziaria dovessero riprendere corpo, l'effetto netto sui tassi di interesse potrebbe addirittura essere al rialzo, con evidenti ripercussioni negative su congiuntura e finanza pubblica. Terzo, l'uscita dalla recessione 2007-2009 è da attribuire in larga parte a manovre fiscali e monetarie a grande scala, dalle quali l'espansione economica sembra essere diventata dipendente, con ovvie controindicazioni.
Infine, è prudente far decidere alla banca centrale il livello "giusto", cioè coerente con l'equilibrio macroeconomico, di valutazione degli asset?
17 ottobre 2010
Primi!
The Economist di questa settimana, stavo navigando la colonna dei rendimenti dei mercati azionari internazionali, per vedere se il nostro si fosse schiodato dai bassifondi. Niente da fare, in dollari la nostra performance dal 31.12.2009 è sempre la terza peggiore dei tanti paesi in lista, meglio solo di Grecia e Spagna...
Poi, l'occhio cade sulla tabella in fondo alla pagina, e lì, invece, l'Italia è PRIMA, addirittura quasi doppiando quei perfezionisti dei tedeschi!
Peccato, si tratta della classifica mondiale del controvalore dei contratti CDS (credit default swaps) sul debito sovrano all'8 ottobre 2010. 28.5 miliardi di dollari di valore nozionale, per un CDS spread di 180 punti base.
Il nostro è tra i debiti pubblici più elevati al mondo, ma la tabella chiarisce che probabilmente è solo in parte per questa ragione quantitativa assoluta che gli investitori domandano così spesso protezione contro il rischio di default dal nostro debito pubblico. In altri termini, si fa largo l'impressione che il livello del debito sia molto prossimo a una soglia critica di sostenibilità.
Anche secondo me a questo problema la politica economica dovrebbe dedicare maggiore attenzione. Ma dovrebbe farlo tenendo soprattutto presente che un indebitamento così elevato ha con ogni probabilità (e secondo una letteratura empirica sempre più chiara) riflessi molto pesanti sulla crescita economica. Soprattutto su produttività e redditività degli investimenti.
Su questo sto facendo una ricerca insieme a un collega australiano. I'll keep you posted!
Poi, l'occhio cade sulla tabella in fondo alla pagina, e lì, invece, l'Italia è PRIMA, addirittura quasi doppiando quei perfezionisti dei tedeschi!
Peccato, si tratta della classifica mondiale del controvalore dei contratti CDS (credit default swaps) sul debito sovrano all'8 ottobre 2010. 28.5 miliardi di dollari di valore nozionale, per un CDS spread di 180 punti base.
Il nostro è tra i debiti pubblici più elevati al mondo, ma la tabella chiarisce che probabilmente è solo in parte per questa ragione quantitativa assoluta che gli investitori domandano così spesso protezione contro il rischio di default dal nostro debito pubblico. In altri termini, si fa largo l'impressione che il livello del debito sia molto prossimo a una soglia critica di sostenibilità.
Anche secondo me a questo problema la politica economica dovrebbe dedicare maggiore attenzione. Ma dovrebbe farlo tenendo soprattutto presente che un indebitamento così elevato ha con ogni probabilità (e secondo una letteratura empirica sempre più chiara) riflessi molto pesanti sulla crescita economica. Soprattutto su produttività e redditività degli investimenti.
Su questo sto facendo una ricerca insieme a un collega australiano. I'll keep you posted!
13 ottobre 2010
Congiunturale o strutturale?
Ci sono tanti modi di affrontare una crisi economica. Rahm Emanuel, ex chief of staff del presidente Obama raccomandava di non sprecare una crisi invano, cioè navigandola senza cogliere le opportunità di riforma e catarsi collettiva che i rallentamenti ciclici offrono.
Secondo me al nostro Paese questa crisi ne offre parecchi di spunti da cui partire per riformare la sua struttura industriale ed economica. Bisognerebbe però non sottovalutare che lo stratagemma del "muddle through", ossia di vivacchiare sperando che l'alta marea, cioè la ripresa globale, risollevi tutte le barche, comprese le carrette del mare.
Che le nostre difficoltà siano di un ordine di grandezza particolare emerge da una lettura anche solo superficiale delle statistiche internazionali. La scorsa settimana il World Economic Outlook dell'IMF ha pubblicato una tabella che mostra come nel decennio 1992-2001 l'economia italiana crebbe in media dell'1.6% all'anno, nettamente meno che le altre maggiori economie europee (Ger, Fra, Spa, UK). Non solo, la somma algebrica bruta delle variazioni percentuali annue di questi Paesi dal 2002 al 2010 (previsione) rende 7.5% per la Germania, 10.4% per la Francia, ben 17.2% per la Spagna e un eloquente 0.9% per l'Italia.
Siamo tutti convinti che le variazioni del PIL siano un indicatore imperfetto della capacità di un'economia di generare benessere. Ma fino a quando non troverò una misura meno imperfetta, ho l'impressione che questi pochi semplici numeri diano una fotografia fin troppo nitida delle nostre debolezze. Strutturali.
Secondo me al nostro Paese questa crisi ne offre parecchi di spunti da cui partire per riformare la sua struttura industriale ed economica. Bisognerebbe però non sottovalutare che lo stratagemma del "muddle through", ossia di vivacchiare sperando che l'alta marea, cioè la ripresa globale, risollevi tutte le barche, comprese le carrette del mare.
Che le nostre difficoltà siano di un ordine di grandezza particolare emerge da una lettura anche solo superficiale delle statistiche internazionali. La scorsa settimana il World Economic Outlook dell'IMF ha pubblicato una tabella che mostra come nel decennio 1992-2001 l'economia italiana crebbe in media dell'1.6% all'anno, nettamente meno che le altre maggiori economie europee (Ger, Fra, Spa, UK). Non solo, la somma algebrica bruta delle variazioni percentuali annue di questi Paesi dal 2002 al 2010 (previsione) rende 7.5% per la Germania, 10.4% per la Francia, ben 17.2% per la Spagna e un eloquente 0.9% per l'Italia.
Siamo tutti convinti che le variazioni del PIL siano un indicatore imperfetto della capacità di un'economia di generare benessere. Ma fino a quando non troverò una misura meno imperfetta, ho l'impressione che questi pochi semplici numeri diano una fotografia fin troppo nitida delle nostre debolezze. Strutturali.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)